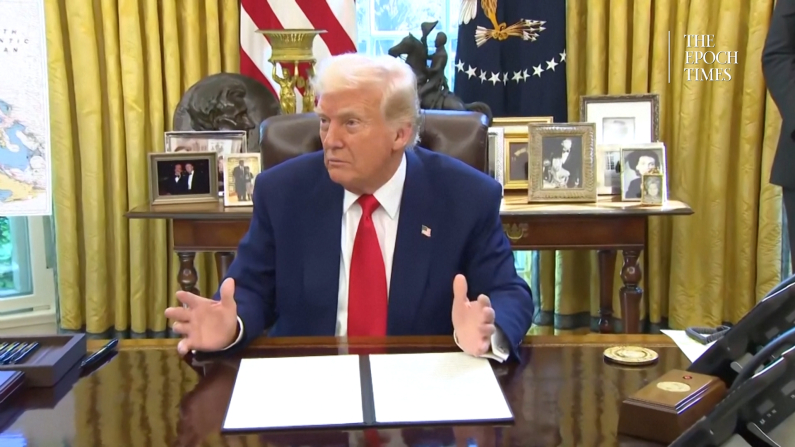Mentre le tensioni commerciali con gli Stati Uniti si intensificano, i dazi di Trump hanno scatenato il panico nei mercati azionari e causato proteste tra i partner commerciali degli Stati Uniti e gli avversari politici del Presidente.
Alcuni economisti faziosi hanno paragonato i dazi di Trump alla famigerata legge Smoot-Hawley del 1930, una norma che ha imposto dazi elevati per proteggere l’economia americana, spesso accusata di aver prolungato la Grande Depressione, anche se studiosi come Amity Shlaes ne attribuiscono la responsabilità in realtà alle politiche del New Deal di Roosevelt.
I dazi decisi da Trump si inseriscono in una strategia geopolitica che riflette la Dottrina Monroe, riducendo il coinvolgimento americano nei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, e promuovendo la diplomazia con Russia e Cina. Il Presidente usa l’economia come leva di politica estera, seguendo l’esempio di Alexander Hamilton, ministro del Tesoro del ‘700 che, con l’approvazione del Parlamento, ha usato i dazi per favorire la produzione interna senza cadere nel protezionismo.
Il ministro del Tesoro Scott Bessent ha citato Hamilton per spiegare l’importanza dei dazi, che generano entrate, favoriscono la produzione industriale e l’occupazione interna e mirano a negoziare accordi commerciali equi con Paesi alleati e avversari.
Bessent considera i dazi un mezzo per gli obiettivi della politica estera di Trump, come spingere i Paesi alleati a investire nella propria difesa, aprire i mercati alle esportazioni americane, combattere l’immigrazione clandestina e il traffico di fentanile, e prevenire inoltre aggressioni militari. Stiamo parlando di un sistema economico direttamente collegato alla geopolitica, un approccio che alcuni studiosi definiscono «geoeconomia».
Hamilton è stato, probabilmente, il primo stratega geoeconomico degli Stati Uniti, con i suoi dazi a supporto della politica estera del Presidente George Washington. Washington, su consiglio di Hamilton e contro il parere di Thomas Jefferson, cercò di instaurare buoni rapporti con la Gran Bretagna, ex nemica, e si rifiutò di sostenere l’alleato francese nel suo conflitto con l’impero britannico. Il discorso di addio di Washington, influenzato da Hamilton, insieme alla sua politica dei dazi, è un esempio calzante di nazionalismo economico e di politica estera America First di Trump.
Lo storico Paul Kennedy, in “Ascesa e declino delle grandi potenze”, ha descritto il legame tra economia e politica estera: «La ricchezza è di solito necessaria per sostenere il potere militare, e il potere militare è di solito necessario per acquisire e proteggere la ricchezza. Tuttavia, se una parte troppo grande delle risorse dello Stato viene tolta per creare ricchezza e viene invece usata a scopi militari, questo probabilmente porta un indebolimento del potere nazionale nel lungo periodo».
La geoeconomia in stile hamiltoniano è stata messa in pratica nel ‘600 da Jean Baptiste Colbert, ministro delle Finanze di Luigi XIV, che usò tasse e dazi per promuovere la produzione interna a favore della sicurezza francese, sviluppando una potente marina e migliorando le infrastrutture. Tuttavia, la politica espansionistica di Luigi XIV, che ha portato a coalizioni nemiche e guerre costose, ha vanificato i successi di Colbert. L’approccio di Trump, in realtà, si avvicina più a quello di Washington e Hamilton che a quello di Luigi XIV.
L’economia come strumento di politica estera è stata fondamentale anche nella Seconda Guerra Mondiale, come racconta Arthur Herman in Freedom’s Forge. La straordinaria mobilitazione dell’industria, della tecnologia e della produzione americana ha trasformato il Paese in un arsenale invincibile. Per quanto riguarda oggi, con la potenza navale di Pechino 200 volte superiore a quella americana, la politica di reindustrializzazione di Trump è più urgente che mai.
La geoeconomia hamiltoniana ha ispirato anche la strategia di Ronald Reagan che gli ha permesso di vincere la Guerra Fredda. Attraverso due direttive di sicurezza nazionale (NSD-66 e NSD-75), Reagan ha adottato un approccio geoeconomico e geopolitico per abbattere l’Unione Sovietica, usando restrizioni commerciali su tecnologie fondamentali, focalizzandosi inoltre sui prezzi dell’energia e sul potenziamento militare, inclusa una marina composta da 600 navi. William Clark, consigliere per la sicurezza nazionale di Reagan, sottolineava quanto la componente economica fosse stata decisiva.
Poco dopo la fine della Guerra Fredda, lo stratega Edward Luttwak, in The Endangered American Dream, ha evidenziato la necessità degli Stati Uniti di puntare sulla geoeconomia come strumento geopolitico, un suggerimento seguito dai leader cinesi ma ignorato da quelli americani. Trump sembra comprendere istintivamente il punto di Luttwak, ribadito di recente su X: i dazi mirano a «ricostruire le industrie americane, indebolite dalla globalizzazione», e «la reindustrializzazione è essenziale, soprattutto per una marina americana senza cantieri navali».
Chi considera i dazi di Trump come un qualcosa a sé stante è fuori strada. In realtà, sono parte della strategia America First per promuovere la manifattura e la reindustrializzazione interna a sostegno degli obiettivi di sicurezza nazionale all’estero. Sebbene le reazioni iniziali dei leader mondiali siano state negative, come riporta Cbs News, molti, inclusi i Paesi che hanno criticato i dazi, stanno cercando di negoziare nuovi accordi commerciali con Trump.
Perché i prodotti americani devono subire dei dazi all’estero mentre gli Stati Uniti permettono importazioni senza dazi equivalenti? Per Trump, commercio libero significa anche commercio equo: l’America viene prima.
Copyright Epoch Times