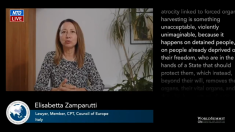Il commercio, che sia interno o con l’estero, è una cosa buona: permette di specializzarsi nella produzione, di raggiungere maggiori livelli di efficienza e quindi di risparmiare materie prime e risorse produttive.
Lo scambio mette in evidenza i punti di forza del singolo, individuo o Paese, e permette a tutti di offrire il meglio della propria produzione, compensando le debolezze produttive altrui. Insomma è un gioco in cui vincono tutti.
Ma il commercio con la Cina non funziona così. Il responsabile del Commercio degli Stati Uniti Robert Lighthizer ha definito la Cina «una minaccia al sistema mondiale del commercio». E in effetti, paragonando la condotta della Cina al vero commercio è evidente come non ci si trovi nella situazione cosiddetta win-win descritta dall’economista classico David Ricardo. E parte della responsabilità è delle precedenti amministrazioni americane.
Il concetto del sistema di libero scambio prevede che le aziende private commercino in beni e servizi e che, alla fine dell’anno, una nazione abbia un avanzo commerciale e l’altra un divanzo. In qualche (raro) caso, importazioni ed esportazioni si equivalgono e la bilancia commerciale è in pareggio. Questa è la situazione migliore possibile.
A questo punto, ipotizzando che – visto il suo bassissimo costo del lavoro – la Cina abbia un avanzo commerciale di 100 dollari con gli Stati Uniti – grazie alla propria capacità di produrre merci a basso costo (e valore) – le aziende e i consumatori cinesi si troverebbero 100 dollari da poter usare in due modi: o mandandoli indietro negli Stati Uniti sotto forma di acquisto di merci o servizi americani ad alto valore e che non possono ancora essere prodotti in Cina (automobili, ad esempio), oppure – in caso i cinesi non trovino alcun prodotto americano di loro gradimento – investendo i loro 100 dollari nel mercato dei capitali statunitense (e, in un sistema realmente libero dall’interferenza del governo, l’investimento sarebbe non in titoli del Tesoro, ma in merci, beni immobili o persino nuovi progetti sperimentali).
Nel primo caso, la Cina sfrutta la propria capacità di produzione di beni a buon mercato, e gli Stati Uniti quella di saper fare meglio le automobili: win-win, tutti vincono. Nel secondo, i cinesi investendo i loro 100 dollari nel debito pubblico Usa rendono – come sempre succede, in modo più o meno diretto e tramite l’azione delle banche – gli Stati Uniti più produttivi poiché, con abbastanza tempo e investimenti, il deficit commerciale viene colmato dalla maggiore competitività dei prodotti americani.
Si tratta naturalmente di una semplificazione teorica: ad esempio, nella realtà sono gli Stati Uniti a essere in disavanzo commerciale nei confronti della Cina (-347 milioni di dollari nel 2016, secondo lo United States Census Buerau), grazie all’aiuto del regime di Pechino, che sovvenziona massicciamente le imprese cinesi affinché possano vendere sottocosto i loro prodotti sui mercati di tutto il mondo (quello che gli economisti definiscono dumping e che, in teoria, sarebbe proibito dall’Organizzazione mondiale del Commercio).
In ogni caso, il modello descritto ha funzionato molto bene in passato: durante la cosiddetta belle époque antecedente la Prima Guerra mondiale, il sistema internazionale di compensazione della bilancia commerciale denominato Gold Standard ha portato a un periodo di crescita di benessere senza precedenti nella Storia. Ma il Gold Standard era aiutato da un solido sistema monetario e da tassi di cambio delle monete fissi, che rendeva il movimento dei capitali più semplice per effetto dell’eliminazione del rischio connesso alle fluttuazioni dei tassi di cambio.
LA REALTÀ DI OGGI
Oggi le cose stanno in modo molto diverso: gli Stati Uniti – la maggiore potenza economica al mondo – accusano un ultra decennale disavanzo commerciale verso la Cina, con un disavanzo che tra il 2001 e il 2016 ammonta a 3.360 miliardi di dollari. Invece di avere i consumatori e le imprese cinesi che acquistano prodotti o titoli di Stato americani, quello che succede è che Pechino emette denaro con cui compra il valore dell’avanzo commerciale (i 100 dollari dell’esempio) incassati da imprese che – fra l’altro – di norma sono di proprietà statale, per poi infine comprare con quel denaro i buoni del Tesoro statunitensi.
Si tratta di un’interferenza notevole nei confronti del funzionamento del mercato: il tasso di cambio dollaro-yuan è mantenuto artificiosamente alto, perché la Banca centrale cinese emette moneta al fine di comprare titoli di debito pubblico americano, facendo così apprezzare il dollaro. E questo rende ovviamente meno competitivi i prodotti americani sul mercato interno cinese. In due modi: prima di tutto perché rende più costosi i prodotti di importazione, e secondo perché Pechino stimola artificiosamente l’economia interna attraverso dei tassi di interesse più bassi del reale, causando un immane eccesso di capacità produttiva delle industrie cinesi. Grazie a questa sovra-capacità produttiva, prodotti che già costerebbero poco (a causa dei bassissimi stipendi pagati agli operai cinesi) diventano ancora più economici.
Tutto questo mentre, dall’altra parte dell’Oceano, le migliaia di miliardi dell’avanzo commerciale cinese, invece di essere investiti nelle imprese americane e innescare il circolo virtuoso, finiscono nel finanziamento del debito pubblico.
Secondo tutti i diversi metodi di calcolo e misurazione, questo investimento nel debito pubblico americano non ha portato a un aumento di produttività delle imprese statunitensi sufficiente a controbilanciare la competitività dei prodotti cinesi, anzi: ha causato una disoccupazione cronica; e sommersa, considerato che le statistiche ufficiali non rappresentano mai diversi milioni di persone uscite dalle liste di collocamento (e quindi dal calcolo ufficiale dalla forza lavoro).
Insomma, nella situazione attuale dei rapporti commerciali Usa-Cina (rispettivamente la prima e la seconda economia del pianeta) più che altro si vedono due governi che non fanno altro che ‘commerciare’ tra di loro moneta, intascandosi i benefici. Di imprese private e cittadini nemmeno l’ombra. E il risultato è un disavanzo commerciale cronico da una parte e un surplus cronico dall’altra.
Certamente gli americani in qualche modo hanno tratto beneficio dai prodotti a basso prezzo, ma è una magra consolazione: sono stati persi milioni di posti di lavoro, e molti di quei prodotti (apparentemente) economici sono stati pagati col denaro pubblico attraverso sussidi di vario genere.
George W. Bush e Barack Obama hanno fatto molto poco per rimediare a questa situazione: entrambe le amministrazioni dipendevano dal flusso di capitali cinesi che finanziavano il crescente debito pubblico. Sotto Bush jr il debito è cresciuto di 5 mila miliardi di dollari, e sotto Obama di 9 mila miliardi; discorsi di circostanza e qualche temporaneo dazio doganale qua e là non hanno cambiato la situazione.
Quanto a Trump, la limitata azione di governo e la posizione «America First» rappresentano più che altro un atteggiamento retorico con pochi fatti. Ma perlomeno Trump ha ordinato un’indagine sul sospetto furto informatico di proprietà intellettuale da parte del regime cinese e, se l’indagine dimostrerà la responsabilità di Pechino, potrebbe risultarne la più dura rappresaglia commerciale mai vista degli Stati Uniti contro la Cina.
IL WTO E IL SCELLERATO ACCORDO FIRMATO DA CLINTON
Quest’analisi relativamente elementare (emblematicamente focalizzata sulle due Superpotenze) tralascia il Wto e le complessità del pessimo accordo che Bill Clinton ha a suo tempo negoziato con la Cina in occasione dell’accesso di quest’ultima appunto all’Organizzazione mondiale del Commercio. Senza contare che Pechino approfitta da sempre delle generose concessioni ottenute, peggiorando la situazione delle imprese e dei lavoratori americani.
Secondo le norme di ammissione al Wto, ad esempio, la Cina avrebbe dovuto abbassare i dazi doganali sui prodotti industriali dell’8,9 percento e di quelli agricoli del 15 percento fino al 2010. Ma il vademecum delle tariffe Wto del 2016 indica che la Cina mantiene i suoi dazi a una media del 10 percento su tutti i prodotti, mentre gli Stati Uniti impongono il 3,5 percento.
Persino secondo le regole del Wto, quindi, la Cina ha un enorme vantaggio competitivo nei confronti degli Stati Uniti (e qui si osserva solo dell’effetto dei dazi doganali).
Senza contare che, al di là della sua vuota retorica sul libero scambio, la Cina ha istituito una nuova politica commerciale, ben spiegata dalla ‘Strategia made in China 2025’ e dal ‘Tredicesimo piano quinquennale per la Scienza e la Tecnologia’. Programmi che aiutano a capire perché Robert Lighthizer accusi la Cina di costituire una minaccia per il sistema del commercio mondiale.
E a pensarla così non è solo Lighthizer: un’analisi della Fondazione per l’informazione, la tecnologia e l’innovazione sostiene che «la Cina non è interessata solo al mercantilismo (cioè minimizzare le importazioni e far esplodere le esportazioni) ma mira all’autarchia: a diventare un’economia chiusa autosufficiente. Il governo cinese lo ha dimostrato a più riprese nei settori dell’acciaio e della cantieristica navale, e ora mira ai settori emergenti come l’aerospaziale, i computer e i semiconduttori, contrapponendosi al principio fondamentale del vantaggio comparativo sotteso al libero scambio di merci del mercato globale».
Per conseguire l’autarchia e il dominio in tutti i settori industriali, Pechino persegue ogni genere di strategia in violazione delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio: acquisisce società tecnologiche straniere, costringe con la forza le società straniere con sede in Cina a trasferire la propria tecnologia o la proprietà intellettuale, sottrae tecnologia attraverso l’hackeraggio e impedisce o limita l’accesso delle imprese straniere al territorio cinese, per citarne solo alcune.
Alla luce di tutto questo, il rapporto sul commercio del World economic Forum 2016 definisce quello cinese come «uno dei più chiusi mercati al mondo», alla 101esima posizione su 136.
In conclusione, la Cina non ha il benché minimo interesse a commerciare in un regime aperto di libero scambio. Al contrario, ha una politica ufficiale di depredazione dei partner commerciali con l’obiettivo di raggiungere un regime autarchico.
Non c’è ragione di sostenere una simile politica, portata avanti da un regime dittatoriale e ostile. Con le parole di Lighthizer: «Dobbiamo trovare altri modi per difendere le nostre imprese, i lavoratori e gli agricoltori. E ovviamente il nostro intero sistema economico. Dobbiamo fare in modo che la nostra economia di mercato prevalga». Ma alle parole dovrebbero seguire anche i fatti.
E tutto questo, ovviamente, non vale soltanto per gli Stati Uniti d’America.
Traduzione di Emiliano Serra
Articolo in inglese: Why Trade With China Is Not Free