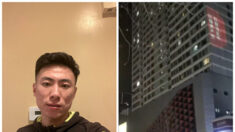di David T. Jones*
Per secoli il commercio internazionale non si è fondato su un’idea di beneficio reciproco, ma piuttosto sulla politica dell’asso pigliatutto. L’obbiettivo dei governi nazionali è sempre stato quello di accumulare la maggior quantità possibile di oro e altri metalli preziosi a scapito dei Paesi più deboli.
Le grandi nazioni storicamente ambivano a creare proprie colonie per poterle sfruttare: estraendo minerali preziosi a basso costo da e rivendendo merci in madre patria. Una simile mentalità naturalmente poteva generare delle circostanze piuttosto spiacevoli, come quando la Gran Bretagna decise che acquistare le foglie di tè pagando in argento era troppo oneroso e iniziò il traffico di oppio in Cina. Persino i deboli sovrani Manciu trovarono inaccettabile questo commercio, ma grazie alla Guerra dell’Oppio, la Gran Bretagna costrinse i cinesi ad accettarlo. Per questo, ancora oggi, i britannici non godono di buona fama in Cina.
Dopo la fine del colonialismo è diventato sempre più diffuso il concetto di ‘beneficio reciproco’, insieme alla Teoria del vantaggio comparato, secondo la quale ogni Paese esporta i prodotti che produce ‘meglio’, prevenendone cosi un eccesso di scorte e riequilibrando la bilancia commerciale.
La teoria però entra in crisi nel caso di Paesi che non producono merci di valore e che quindi finiscono per indebitarsi con le nazioni che continuano a vendere loro i propri prodotti. E col tempo i pesanti debiti finiscono per avere un effetto distorsivo sull’economia di entrambi: debitori e creditori.
Un approccio classico, che un Paese può adottare per favorire lo sviluppo della propria industria e il fiorire dell’economia interna, è quello di imporre tasse molto alte sulle importazioni. Per poi ridurle o eliminarle quando le proprie industrie diventino abbastanza forti da ‘stare in piedi da sole’. D’altra parte questo genere di approccio non porta vantaggi alle industrie ormai ‘crescite’, che non traggono alcun giovamento dall’aumento della concorrenza.
Per un’intera generazione dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti commercialmente parlando non hanno avuto rivali: erano i primi al mondo per efficienza produttiva e innovazione tecnologica. Inoltre i prodotti americani, in particolare le automobili, potevano contare sulla vasta domanda interna: per l’operaio medio era normale guadagnare abbastanza da non dover rinunciare a nulla. E non c’erano automobili straniere degne di essere importate (a parte la risibile nicchia delle Volkswagen). Il surplus commerciale degli Stati Uniti cresceva costantemente, al punto di renderli i principali creditori al mondo. Le merci importate dall’estero venivano considerate di scarsa qualità, generando solo un barlume di concorrenza nel settore di fascia bassa.
Ma all’improvviso l’incantesimo si è infranto. I Paesi rivali avevano iniziato a costruire nuove industrie e usare tecnologie moderne, a sfruttare la manodopera a basso costo e approfittare dei fallimenti tecnologici americani, dei prezzi troppo alti e dell’arroganza sociale.
I giornali erano colmi di articoli e ricerche che prevedevano che il Giappone sarebbe presto diventato il leader mondiale in ogni settore. Il governo Usa sventò il tentativo giapponese di comprare un’azienda di computer strategica (che si sarebbe poi evoluta in Intel), e iniziò a concentrare i propri sforzi per ostacolare il Giappone e poi anche il Messico, il cui lavoro a basso costo, secondo il miliardario Ross Perot, stava danneggiando l’economia americana.
Ma mentre gli americani erano focalizzati sul Giappone e sul Messico, la Cina, silenziosamente ed efficacemente riusciva a «mangiarsi il loro pranzo» (e anche una buona parte della cena). Oggi la Cina dispone di un enorme disavanzo commerciale per via della capacità produttiva e della manipolazione valutaria. È senz’altro definibile come la ‘fabbrica del mondo’, e il leader cinese Xi Jinping ha annunciato un programma denominato ‘Made in China 2025’, che mira a «soddisfare la domanda interna e porre fine alle importazioni straniere».
Durante gli ultimi 20 anni negli Stati Uniti sono scomparsi circa due milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero. E chi ha perso il lavoro lo deve almeno in parte agli accordi commerciali che hanno ridotto il costo delle importazioni: per loro la riqualificazione professionale e lavorare in un fast food sono delle alternative risibili.
Per questo Donald Trump fa pressione affinché vengano revocati accordi commerciali come il Partenariato Trans-Pacifico e ridiscussi seriamente trattati come il Nafta e i trattati bilaterali con Paesi come la Corea del Sud.
Trump sostiene che gli Stati Uniti abbiano commesso doversi errori e si siano fatti «mettere nel sacco» siglando questi trattati, e che non basterà qualche piccola modifica per riequilibrare la situazione. Senza dubbio i suoi discorsi hanno incontrato il favore degli elettori, se non quello degli economisti.
Ma la Cina resta un argomento difficile da trattare. Specialmente ora che Washington sta disperatamente tentando di indurre Pechino a neutralizzare il programma nucleare di Pyongyang. Benché si prevedano parole pesanti, sarà difficile modificare concretamente gli attuali accordi bilaterali (ad esempio sarà difficile garantirsi l’accesso al mercato cinese e porre fine ai furti di proprietà intellettuale).
Ma, sebbene attualmente sia solo una vaga idea, un’azione coordinata di Usa, Unione Europea e Wto (Organizzazione mondiale del commercio) potrebbe costringere la Cina a rispettare di più i regolamenti Wto.
* David T. Jones è un ex alto funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha pubblicato diverse centinaia di libri, articoli e recensioni sulle questioni bilaterali Stati Uniti-Canada e sulla politica estera in generale. Nel corso di una carriera di oltre 30 anni, si è concentrato su questioni politico-militari, ed è stato consulente per due capi di stato maggiore dell’esercito americano.
Quelle espresse in questo articolo sono le opinioni dell’autore e non riflettono necessariamente la posizione di Epoch Times.
Articolo in inglese: Trade and the China Challenge
Traduzione di Marco D’Ippolito